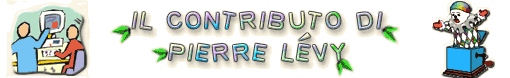
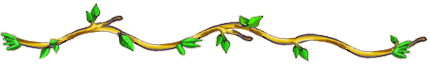
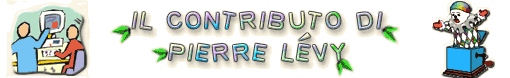
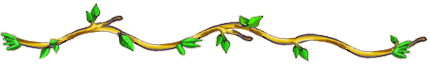
|
"La rapidità di rinnovamento dei rami del sapere e del know-how è la prima delle caratteristiche della cybercultura, della cultura cioè che più sta influenzando la società contemporanea". Questa considerazione è di uno studioso francese, Pierre Lévy, ed è contenuta in un suo articolo che ha per tema "La cybercultura e l'educazione" e del quale qui di seguito riporteremo una breve sintesi. In quest'articolo egli si propone di indagare sulle mutazioni del rapporto con il sapere che l'introduzione dei nuovi media ha comportato nella cultura di fine secondo millennio d.C. La seconda caratteristica di questa cultura, secondo Lévy, è legata al fatto che tale rapidità di cambiamento del know-how ha mutato radicalmente la natura del lavoro, in quanto attualmente lavorare "equivale sempre più ad apprendere, trasmettere sapere e produrre conoscenze". Terzo aspetto rilevato riguarda la natura delle tecnologie intellettuali che attualmente vengono utilizzate. Esse "amplificano, esteriorizzano e modificano un gran numero di funzioni conoscitive umane": la memoria, essendo possibile ora immagazzinare un numero sempre crescente di informazioni, l'immaginazione, attraverso le simulazioni, le percezioni, con la creazione delle realtà virtuali ed i ragionamenti, con l'intelligenze artificiali e la modellazione di fenomeni complessi. Ciò favorisce un nuovo accesso all'informazione e nuovi stili di ragionamento e conoscenza. Di tutto ciò deve tener conto, secondo Lévy, chi si occupa di educazione e formazione, in quanto ciò che si deve apprendere non può più essere anticipatamente pianificato, né precisamente definito. In tal senso egli invoca una doppia riforma, una rivolta ad un nuovo stile di pedagogia, che favorisca sia gli apprendimenti personalizzati che l'apprendimento cooperativo in rete, l'altra che riguardi le istituzioni private e pubbliche che sono adibite alla diffusione ed alla trasmissione del sapere, "facendosi queste carico di orientare i percorsi individuali nel sapere e di contribuire al riconoscimento dell'insieme dei know - how in possesso delle persone, inclusi quelli non accademici". Questo riconoscimento avverrebbe utilizzando test automatizzati accessibili in qualsiasi momento ed allestendo reti di transazione tra offerta e domanda di competenza, in grado di organizzare meglio la comunicazione tra datori di lavoro, individui e risorse di apprendimento di ogni ordine. Quest'ultimo compito Lévy lo affida alle Università dell'avvenire, ma noi aggiungiamo che si potrebbe pensare anche per la scuola e per tutte le realtà come le ludoteche che si occupano di educazione e formazione cercando di offrire concretamente a tutti gli individui la tranquillità e la possibilità, non solo ufficiale o annunciata ma reale, di crescere ed imparare attraverso un proprio cammino di scoperta del sapere. Tra i nuovi media, poi, egli sofferma la sua attenzione sul Web descrivendolo come un qualcosa "privo di recinzioni semantiche o strutturali e non fissato nel tempo, in quanto si gonfia, si muove e si trasforma in permanenza, muovendosi a flusso, a fiotto". Bisogna abituarsi al "diluvio" di informazioni e al disordine che ne consegue, convincendoci che l'impresa di Diderot e D'Alambert che "racchiusero" il sapere nella loro "grande enciclopedia" è qualcosa che oggi appare illusorio poiché la conoscenza "è passata nella sfera dell'intotalizzabile, del non padroneggiabile". Ogni individuo ed ogni gruppo di individui dunque "ha bisogno di costruire significato, di ricavare zone di familiarità, di addomesticare il caos circostante". Ai tempi della prima oralità la "conoscenza del sapere" era propria degli anziani, ai tempi della scrittura era propria di chi interpretava i testi, con l'invenzione della stampa la conoscenza è posseduta dal dotto e dallo scienzato, oggi invece il sapere si è detotalizzato, si è deterritorializzato in un contesto in cui il "sapere potrebbe essere portato dalle collettività umane viventi, piuttosto che da supporti separati, serviti da interpreti o da scienziati". A differenza però della prima oralità il portatore "diretto" del sapere non sarebbe più la comunità fisica, gli anziani e i saggi, ma il cyberspazio, composto da mondi virtuali, e al tempo stesso reali, aggiungiamo noi, tramite i quali le comunità scoprono e costruiscono i loro oggetti e si riconoscono come collettivi intelligenti. È ai nuovi media che l'Uomo sta affidando il compito di custodire e trasmettere il sapere, e non più solo alle astrazioni teoriche. Secondo Lévy "le basi di dati di immagini, le simulazioni interattive e le videoconferenze assicurano una conoscenza più approfondita del mondo rispetto all'astrazione teorica passata in secondo piano". Noi aggiungiamo che è comunque anche grazie alle metafisiche ed alle astrazioni che si possono ideare approcci o sviluppare programmi di ricerca e di costruzione e trasmissione del sapere. Sempre attenti quindi a considerare fondamentale ed insostituibile la "risorsa umana". Può sembrare banale ma non dimentichiamo il cinema: "2001: Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick. Ad un'intelligenza artificiale viene affidato il compito di guidare una missione di astronauti su Giove per recuperare il "monolite nero" e questa si ribella all'uomo tramando e quasi portando a termine il progetto di eliminare il resto dell'equipaggio. Fantascienza si dirà ma che dire dell'Informazione di oggi e della fantascienza del "Grande Fratello" in "1984" di George Orwell? Forse è fantascienza ma anche oggi esiste una sorta di "grande fratello" o almeno esistono tentativi di portare a termine, da parte di qualcuno, progetti che perseguono il "dominio". Forse esageriamo forse no. La componente ludica e il progetto di divertirsi ed al tempo stesso educare giocando sono elementi che potrebbero permettere un giusto approccio ed una familiarizzazione con nuovi "utensili". L'idea di "edutainment" (educational and entertainment) può avere anche questa valenza: giocare per rendere gli utensili delle macchine nate per migliorare la qualità della vita, senza che essi si ribellino. La nuova cultura è caratterizzata dalla possibilità di "interconnessione in tempo reale di tutti con tutti e ciò provoca disordine". Questa possibilità di interconnessione però favorisce anche "i processi di intelligenza collettiva nelle comunità virtuali, grazie alla quale l'individuo si ritrova meno sprovveduto di fronte al caos informazionale". È per questo, secondo Lévy, che "l'ideale di mobilitazione dell'informatica non è più l'intelligenza artificiale, rendere cioè una macchina intelligente quanto o addirittura più di un uomo, bensì l'intelligenza collettiva, vale a dire l'utilizzazione ottimale e la messa in sinergia delle competenze, delle immaginazioni e delle energie intellettuali". In questo processo l'educazione, e di conseguenza il ruolo degli educatori e dei formatori, cambia nel senso di un apprendimento cooperativo, in cui gli insegnanti diventano animatori dell'intelligenza collettiva dei gruppi di loro competenza, utilizzando un nuovo approccio educativo, approccio che come abbiamo visto deriva dalle caratteristiche stesse degli strumenti tecnologici utilizzati. Lévy rivolge poi una sorta di appello, fornendo una descrizione di quello che secondo la sua esperienza dovrebbe essere il ruolo dei poteri pubblici e delle istituzioni che attendono all'educazione ed alla formazione:
L'appello lanciato da Lévy sul ruolo delle istituzioni pubbliche noi vorremmo lanciarlo a tutte le realtà, sia pubbliche che private, che si occupano di educazione e dunque anche alle ludoteche, che hanno la possibilità di perseguire questi obiettivi in un clima divertente perché legato al gioco, attraverso gli sviluppi che l'idea di edutainment può comportare nell'avvicinare tutti alle nuove tecnologie. |